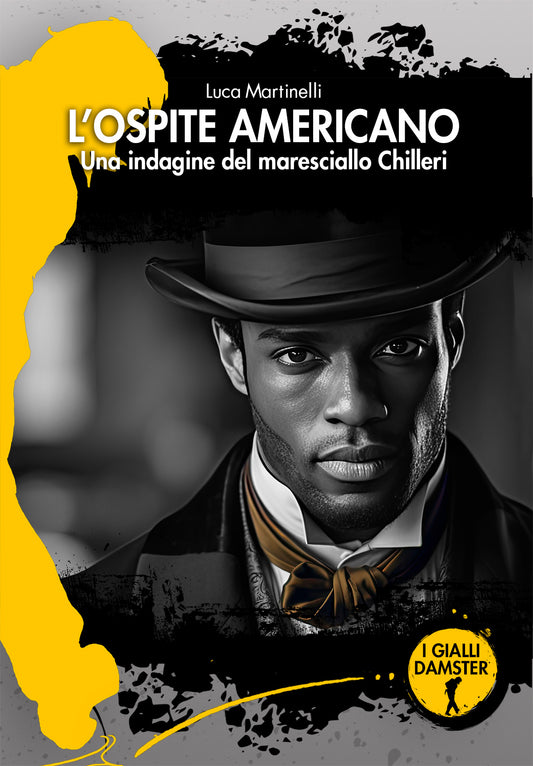Giorgio Chilleri, maresciallo del Carabinieri Reali, è il comandante della stazione di Prato, città toscana non lontana da Firenze, dove è in grande espansione l’industria tessile. Al comando della locale stazione dei Carabinieri è arrivato nel 1904, all’età di oltre cinquant’anni e dopo una lunga carriera nell’Arma, come ultimo incarico in attesa del momento di andare in pensione.
A Prato Chilleri si trova a fare i conti, per la prima volta, con il mestiere di investigatore.
Fino ad allora, infatti, la sua carriera nell’Arma era stata solo di stampo militare. Indossata la divisa da giovanissimo, poco più che ventenne aveva fatto parte del contingente che fu protagonista della breccia di Porta Pia; dopo qualche tempo si era poi imbarcato alla volta del Corno d’Africa. per prestare servizio nelle colonie; infine nel 1900, ancora via nave, era stato aggregato al corpo di spedizione in Cina, dove finita la guerra dei boxer le potenze europee, al fianco degli Stati Uniti, colonizzarono alcune aree di quel vasto paese. Nel corso di queste campagne, l’Arma dei Carabinieri aveva svolto essenzialmente compiti di polizia militare (vigilavano cioè sui corretti comportamenti dei soldati impegnati sul campo), anche se non erano mancate occasioni di partecipazione diretta ad alcune battaglie. Chilleri, dunque, per tutti quegli anni, non si era mai misurato con il mestiere di investigatore. Nella città di Prato, invece, conoscerà il mondo del crimine e, a dispetto dell’inesperienza, dovrà impegnarsi a combatterlo.
L’impatto con le indagini è disastroso. Il primo caso di rilievo che deve affrontare nell’autunno del 1904 si rivela un completo fallimento. Chilleri viene chiamato a indagare sulla misteriosa morta di una donna, trovata impiccata a un ulivo nella campagna a nord della città. Priva di documenti e con una scena del crimine piena di contraddizioni, Chilleri non riesce a dare un’identità alla donna né a spiegare l’esatta dinamica della sua morte. Alla fine, anche se convinto che la vicenda non sia affatto lineare, dovrà alzare bandiera bianca e accettare la decisione del magistrato, che chiude il caso classificandolo come suicidio.
È con il peso di questo senso di fallimento (solo evocato dai pensieri del maresciallo, dal momento che quella vicenda non è mai narrata) che Chilleri, un anno dopo, si troverà alle prese con l’omicidio di Violetta Marconi, interprete commerciale per molte aziende tessili pratesi di cui si sospetta una doppia e piccante vita. Chilleri affronta l’indagine col piglio del militare, ma in preda a mille dubbi e mille difficoltà. La raccolta e l’analisi di indizi e prove, attività a lui poco familiare, lo porteranno a compiere errori di valutazione, a mettere sotto accusa persone innocenti, anche a lui vicine, per poi rendersi conto, con amarezza, di aver commesso un errore. Con lo spettro di andare incontro a un nuovo fallimento, sarà solo per merito della sua strenua tenacia e forza di volontà che alla fine, anche beneficiando di un piccolo colpo di fortuna, riuscirà a risolvere il caso.
Da quell’indagine, e da un incontro con un personaggio inglese che evocherà nel corso di una successiva indagine, Chilleri ha imparato che nell’affrontare un crimine nulla deve essere dato per scontato, che ogni indizio va valutato, che ogni intuizione va verificata prima di tirare qualsiasi conclusione. La stessa lezione ricava in parte anche dalla lettura delle avventure poliziesche pubblicate su alcune riviste. Eppure, la sua impulsività a volte finisce per prevalere su tutto e l’indagine non si sviluppa mai in modo lineare e senza errori.
Chilleri, insomma, è il perfetto anti Sherlock Holmes. Per quanto è un campione di logica il detective inglese, tanto è un campione di umana incertezza il maresciallo. Eppure, per quanto faticosamente, il suo senso del dovere e la capacità di intuizione e di ragionamento, quando riesce a controllare i suoi impulsi, lo portano alla soluzione del mistero.
Oltre a essere un buon militare e un volenteroso e tenace investigatore, il maresciallo Chilleri, per quanto di carattere riservato, è un uomo privo di pregiudizi e ha una visione delle cose del mondo assai aperta, per certi versi progressista. Crede fermamente nel concetto di giustizia e in quello di libertà (inteso anche riguardo alle sfere più intime delle persone) e non esprime mai giudizi avventati sui suoi simili. Anzi, contesta chi esprime sentenze riguardo ai comportamenti umani, all’appartenenza di razza, ai convincimenti politici o religiosi, ai costumi sessuali. In tutto questo, certamente, il suo aver girato il mondo ne fa un personaggio fuori dal coro, estraneo al contesto sociale della città in cui imperano il moralismo e il pettegolezzo.
A Chilleri fa da contraltare il giornalista Luca Bellini, che invece del moralismo, anche bieco, e del pettegolezzo, anche il più sconveniente, fa le armi del suo mestiere e il fondamento delle sue discussioni pubbliche. E Bellini, con i suoi articoli pieni di critiche all’indirizzo degli investigatori, è la spina del fianco del maresciallo, è quello che gli fa perdere le staffe e che gli fa riportare a galla le sue insicurezze.
Eppure, Bellini, insieme con l’ex maestro elementare Pancrazi e il farmacista Carlesi, ogni domenica siede con Chilleri al tavolo dell’osteria o nel palco del Teatro Metastasio. Ma del resto, in una realtà così piccola, come tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento succedeva in comunità analoghe, la frequentazione tra le “autorità” da tutti riconosciute come tali era uno dei caposaldi della vita cittadina. Spesso (ed è questo anche nel caso di Chilleri) a legare questi personaggi, anche in virtù della stratificazione per classi della società, era solo e soltanto il ruolo sociale che essi ricoprivano, senza che tra loro si determinasse alcun vincolo di amicizia. Così era inevitabile, per il maresciallo Chilleri, passare la domenica serata in compagnia del maestro e del farmacista e, per quanto a volte gli fosse sgradito, anche col giornalista Bellini.
A fargli da spalla, il giovane brigadiere Valenti, bolognese, un gran lavoratore che, sebbene non troppo perspicace da un punto di vista investigativo, è però capace, grazie alle sue domande e ai suoi dubbi, di frenare le derive alle quel il maresciallo Chilleri si lascia trasportare dall’impeto del carattere.
La vita privata e sentimentale del maresciallo Chilleri, infine, è un puzzle di cui si conoscono poche tessere: ama leggere e fare passeggiate che lo aiutano a calmarsi quando le cose vanno per il verso sbagliato; è stato innamorato di una giovane ragazza romana all’epoca della breccia di Porta Pia; nel Corno d’Africa ha avuto una lunga storia d’amore con Habibi, una donna eritrea che considera essere stata sua moglie anche se non si sono mai sposati; a Prato frequenta segretamente una prostituta, di poco più giovane di lui, perché nell’unione delle loro due solitudini Chilleri è convinto di aver ritrovato il sottile equilibrio della sua vita più intima e privata.